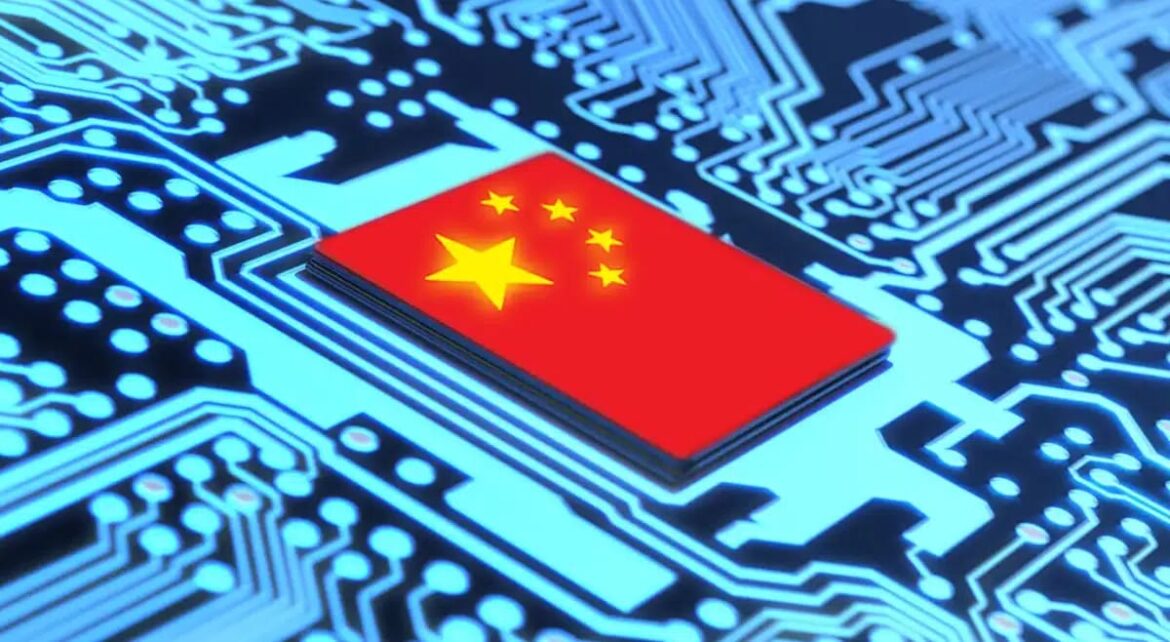Roma, 14 ott – Lo scontro geopolitico tra superpotenze trova nella tecnologia un campo di battaglia in continua ascesa. A pochi giorni dalla conclusione della grande Global Digital Trade Expo di Hangzhou, dove la Cina ha messo in vetrina il proprio comparto high-tech, Trump ha minacciato una nuova ondata di dazi in seguito all’inasprimento cinese delle regole sulle esportazioni di terre rare e tecnologie correlate. Mentre Washington mantiene ancora il titolo di prima potenza tecnologica globale, Pechino continua una serie di colpi strategici per tentare di rovesciare il dominio Usa. Tra queste iniziative che tanto hanno causato l’ira della Casa Bianca, c’è l’inserimento di altri cinque elementi essenziali per tecnologie laser (come olmio ed erbio) in una speciale lista di minerali a cui è imposto l’obbligo di licenza e permessi speciali. Tutto questo, come ha espresso il ministero del Commercio cinese, per “salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali”.
Il piano tecnologico cinese
La Cina, negli ultimi venti anni, ha accelerato in modo consistente su diversi settori tech. Dalla manifattura al 5G, passando per l’intelligenza artificiale e i chip. Ma in che modo il colosso asiatico è rapidamente diventato una vera e propria potenza tecnologica? Verso la metà del secolo scorso, la Cina comunista ha avviato una seria opera di modernizzazione con l’obbiettivo di “riprendere il Regno Unito e superare gli Stati Uniti”, così come recitava un noto slogan di Mao.
Con il rovescio delle politiche figlie della Grande rivoluzione culturale, la quale aveva portato alla quasi totale scomparsa di nuovi scienziati, ingegneri e intellettuali per circa un decennio, dalla fine degli anni ’70 ci fu una forte promozione della scienza e della tecnologia, grazie anche alla riforma economica cinese nota come “riforma e apertura”. Nel 1995, il Consiglio di Stato emanò la “Decisione sull’accelerazione dello sviluppo della scienza e della tecnologia”. Pianificando così lo sviluppo per i decenni successivi e, di fatto, segnando l’ascesa a cui assistiamo ora. Oggi, infatti, la Cina ha superato gli Stati Uniti nel numero di robot industriali. E, oltre a dominare il mercato globale di droni e produzione automobilistica, ricopre un ruolo di primo piano in settori come “Internet of Things” e IA.
Cina, la tecnica non è mai esistita
Ma in questo grande processo di accelerazione che ha portato la Cina a situarsi tra le grandi potenze, è possibile rintracciare un pensiero tecnologico specificatamente cinese? Una domanda non semplice a cui ha cercato di rispondere Yuk Hui, filosofo di Hong Kong e allievo di Bernard Stiegler, una voce che negli ultimi anni si è rivelata decisiva tra i teorici della tecnologia. Nel suo saggio “Cosmotecnica. La questione della tecnologia in Cina” (Nero, 2021), Yuk Hui cerca di sviluppare una filosofia della tecnologia cinese attraverso un approccio che rilegga il pensiero tradizionale di alcuni filosofi asiatici alla luce delle riflessioni sulla tecnica di autori come Heidegger, Simondon e Stiegler.
La tesi centrale di Yuk Hui si sviluppa sull’affermazione che “in Cina, la tecnica nel senso in cui la intendiamo oggi – o almeno in cui è definita da alcuni filosofi europei – non è mai esistita”. Da qui, il filosofo hongkongonese introduce il concetto di cosmotecnica, ovvero “l’unificazione tra ordine cosmico e ordine morale per mezzo di attività tecniche”. Questo neologismo offre al filosofo asiatico uno strumento concettuale per superare la convenzionale opposizione tra tecnica e natura, cercando di comprendere l’unità organica tra le due.
Cosmo e tecnica
Yuk Hui, partendo da una critica alla modernità, si scaglia (senza cadere nei meandri della critica postcoloniale) contro l’idea implicita che esista un solo tipo di tecnica e un solo tipo di tecnologia, le quali verrebbero così considerate universali. Dialogando con la tradizione del pensiero tecnologico, fino ad interrogarsi in merito a proposte quali il Prometeismo o l’accelerazionismo, Yuk Hui presenta la relazione tra le categorie filosofiche cinesi di Qi (letteralmente “strumenti”) e Dao (spesso traslitterato in tao) come fondamentale per ripensare la tecnologia.
Questa riattualizzazione della metafisica tradizionale cinese, con l’unificazione tra il Cielo e l’umano attraverso riti, strumenti e tecniche, apre le porte a una pluralità di approcci che includono tecnologia, mitologia e cosmologie differenti. Lo stesso filosofo di Hong Kong, citando il Nietzsche de La Gaia scienza, percepisce il naufragio dell’individuo nei tempi moderni e, di conseguenza, la necessità di dover affermare una prospettiva tecnica radicalmente alternativa alla globalizzazione e al paradigma iper-capitalistico e consumistico che ha abbracciato la tecnica stessa.
Riaffermare il Mito
Contro l’errata concezione della tecnica come qualcosa di universale, strettamente razionale e strumentale, Yuk Hui riabilita una sorta di pensiero magico e mitico. Per lui, “qualsiasi demitologizzazione è accompagnata da una remitologizzazione”, un’origine dalla quale la filosofia non si può mai del tutto staccare. Seguendo la storia speculativa della tecnicità di Simondon, Yuk Hui evidenzia come la genesi della tecnologia sia segnata da una iniziale fase magica nella quale troviamo un’unità originaria che precede la scissione soggetto/oggetto. Il magico conserva quindi una continuità con lo sviluppo della scienza e della tecnologia. Una volta accettato il concetto di cosmotecnica, infatti, saremo in grado di superare l’opposizione e la progressione tra magia/mito da una parte e scienza dall’altra.
L’ecologia proposta da Yuk Hui unisce e riconcilia tecnica, morale, mito e natura in una dinamica di relazioni continue. Un pensiero radicale e alternativo che, nel suo tentativo di superare le intemperie della modernità, offre una possibile chiave di lettura per comprendere l’accelerazione cinese degli ultimi decenni. Tra speculazioni interessanti e divergenze strutturali, le proposte di Yuk Hui possono risultare utili per concepire una cosmotecnica specificatamente europea che sappia riconciliare il pensiero mitico delle origini con nuove prospettive.
Andrea Grieco