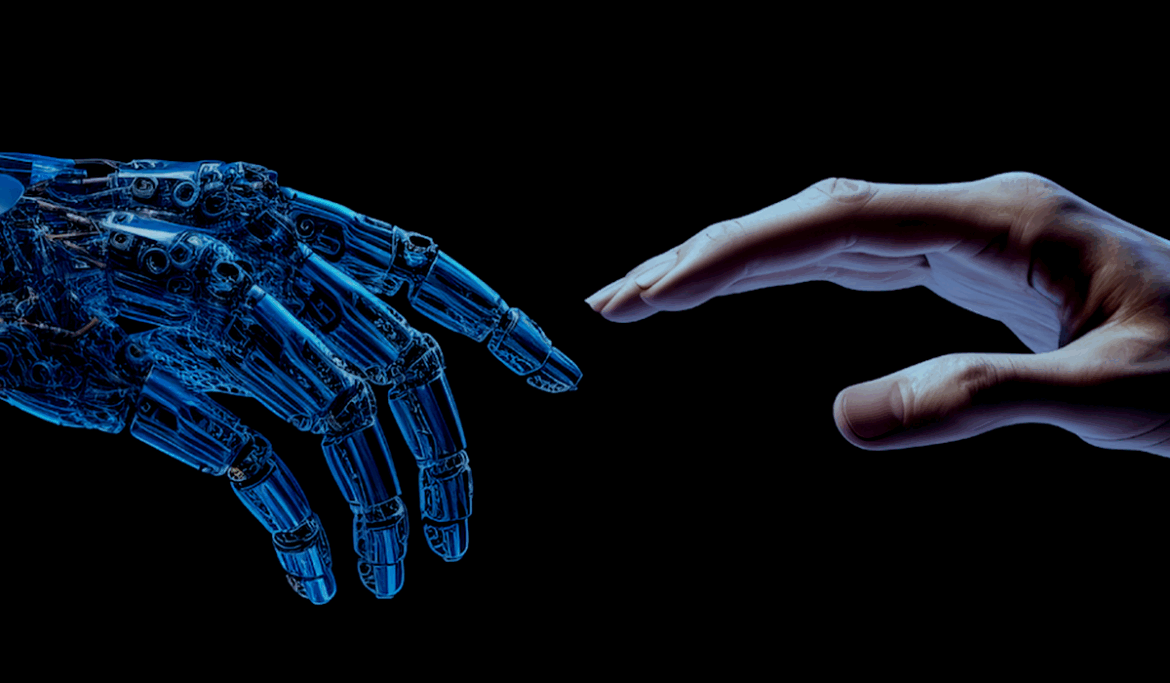Roma, 29 ago – Il sistema scolastico italiano è travolto da parole d’ordine che si rincorrono da anni: “innovazione digitale”, “Scuola 4.0”, “PNRR”. Termini che evocano rivoluzioni epocali, ma che rischiano di tradursi in un’operazione cosmetica, fatta di IA, tablet, LIM e arredi modulari. La retorica dell’innovazione spesso si arresta alla superficie, mentre resta intatta la vecchia ossatura burocratica e conformista del sistema.
IA e scuola: uno nodo culturale
Come sottolineato in passato proprio qui sul Primato Nazionale, l’intelligenza artificiale è ancora lontana dall’essere una “vera intelligenza”: si tratta di un gigantesco apparato linguistico-computazionale che riproduce sintassi senza però incarnare esperienza. Il rischio quindi non è tanto ritrovarsi Skynet nelle classi, quanto quello di conservare (e potenziare) la scuola come luogo di nozionismo, delegando alle macchine il ruolo dei docenti e cancellando per sempre ciò che invece dovrebbe essere vissuto nella relazione e nella corporeità. L’IA, in fondo, non fa che restituire un’immagine speculare della didattica che trova: se l’educazione si riduce a schede e test, allora l’algoritmo potrà solo amplificarne la sterilità. La vera sfida quindi non è tecnologica, ma antropologica: una scuola che vuole davvero educare deve andare oltre l’idea di conoscenza come informazione, riscoprendo l’unità di corpo e mente, esperienza e concetto, disciplina e creatività. Se la scuola resta una fabbrica di conformismo, l’IA non sarà che il suo ultimo travestimento. Ma se tornerà a essere palestra di libertà, allora la tecnologia potrebbe diventare un’arma della nostra identità, non della nostra alienazione.
La scuola di domani premierà di più i Gianburrasca
Ma questo non lo diciamo noi. Cinquantacinque istituti del Friuli Venezia Giulia hanno messo insieme un documento che, al netto delle cautele, è probabilmente il più serio mai elaborato sul tema. Cosa dice questo studio proveniente dal “basso” e non da linee ministeriali? Che l’impatto dell’IA dipenderà in larga parte dal dialogo educativo che troverà davanti. Se questo dialogo è povero, ridotto alla mera trasmissione di nozioni e alla verifica formale della loro acquisizione, allora l’algoritmo non farà altro che renderlo ancora più sterile, fino a cancellare ogni residuo di originalità: diventerà quasi impossibile distinguere il lavoro reale dello studente (o di un docente) da quello prodotto da una macchina. Ma se invece la relazione tra docenti e alunni si fonda su fiducia, responsabilità condivisa e co-costruzione del sapere, l’IA può trasformarsi in un alleato utile, in grado di stimolare creatività, motivazione e perfino nuove forme di valutazione autentica e continua. Lapalissiano: l’IA non inventa nulla ma amplifica ciò che trova. È uno specchio, che riflette la qualità della didattica e della cultura scolastica in cui viene inserita. Illuminanti in questo senso le parole di Vincenzo Caico, dirigente dell’ISIS “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone e coordinatore del gruppo si lavoro su IA. “Una possibile strategia – dice – consiste nell’individuare e valorizzare quelle caratteristiche che sono e resteranno esclusivamente umane. In particolare, l’essere umano ha, in virtù della sua dimensione esistenziale, un contatto diretto con la vita che l’IA – almeno finché non avrà un corpo destinato a vivere, godere, soffrire, sognare, morire – non ha. Forse la scuola di domani premierà di più i Pinocchio e i Gianburrasca. L’adesione alla regola, obiettivo di una umanità disordinata, potrebbe non essere più così apprezzabile. Se la macchina è perfetta, l’essere umano dovrà trovare nell’imperfezione geniale la sua ragion d’essere”.
Valditara e la “rivoluzione conforme”
Sul fronte politico, Valditara ha presentato le sue riforme come un cambio di passo, ma in realtà si tratta di una rivoluzione conforme, che riproduce le stesse logiche di controllo, buon senso amministrativo e conformismo culturale del passato. Dietro le grandi parole si intravede l’ennesimo tentativo di adattare la scuola alle esigenze immediate del mercato. Più efficienza, ma senza ridiscutere la sua funzione più profonda: formare uomini liberi e comunità pensanti. Il rischio quindi è duplice: da un lato, sprecare i fondi del PNRR in un accumulo di dispositivi destinati a restare sottovalutati e sottoutilizzati (chi formerà i docenti all’utilizzo delle IA?); dall’altro, consegnare definitivamente l’educazione al paradigma liberale che produce uniformità invece che identità. In questo contesto, si dirà che i dirigenti scolastici dovranno adottare sempre più autonomia, che non dovranno più limitarsi al ruolo di funzionari, che dovranno essere “leader educativi” capaci di indirizzare l’uso delle tecnologie verso un disegno pedagogico e non verso un vuoto efficientismo. Tutte belle speranze, che sappiamo già come si concluderanno: l’IA diventerà uno strumento per monitorare assenze e voti, prevedere abbandoni, “alleggerire” la burocrazia dei presidi. “Non sarebbe poco”, penserà qualcuno: ma serviva la più grande rivoluzione tecnologica dopo la fissione nucleare per abbattere la burocrazia? Il world wide web esiste dal 1991…
Troppo digitale? No, troppo vecchia
Ed è qui che sta il nodo politico. Perché in Italia, più che altrove, la tecnologia viene usata per irrobustire vecchie strutture anziché scardinarle. Il rischio non è che la scuola diventi “troppo digitale”, ma che resti terribilmente vecchia dietro una facciata nuova. Strutture inadeguate, programmi obsoleti, didattica standardizzata. In fondo, lo abbiamo già visto: le LIM, celebrate dai primi anni del 2000 in poi come rivoluzione didattica, sono finite a fare le veci delle lavagne; i registri digitali, nati per semplificare, hanno solo aumentato il controllo burocratico su studenti e docenti. Ora l’IA rischia di seguire la stessa traiettoria: invece di liberare energie e creatività, potrebbe essere ridotta a strumento di sorveglianza, utile a monitorare più che a educare. Se il PNRR offre risorse mai viste, senza una visione tutto si ridurrà a un accumulo di device. Va detto chiaramente: ben vengano laboratori, strumenti digitali, aule rinnovate. Ma se il loro uso resta ancorato alla logica del “controllo” e della “normalità” propugnata da Valditara, allora la scuola italiana continuerà a produrre studenti passivi, ridotti a utenti da monitorare. Il nodo etico in questo senso è cruciale. No, non si tratta della solita retorica sulla “disumanizzazione” ma non bisogna nemmeno essere ingenui: gli algoritmi non sono neutri, riflettono logiche di potere e di mercato. Se la scuola li adotta senza spirito critico, rischia di ampliare le disuguaglianze, riducendo lo studente a consumatore digitale. Solo se governati con coscienza e disciplina, possono trasformarsi in strumenti di partecipazione, sperimentazione e comunità.
L’IA come strumento di emancipazione
La tecnologia, se ha un senso rivoluzionario, è quello di mettere in discussione schemi e rigidità, non di rafforzarli. Insomma, non basta fornire dispositivi (o vietarli). Occorre educare alla padronanza tecnologica — insegnando disciplina digitale e responsabilità in primis ai docenti — per formare una comunità scolastica capace di governare la tecnica, non di subirla. Solo così il PNRR e l’IA potranno davvero diventare leve di emancipazione culturale e politica, non surrogati consolatori o strumenti di alienazione.
Sergio Filacchioni