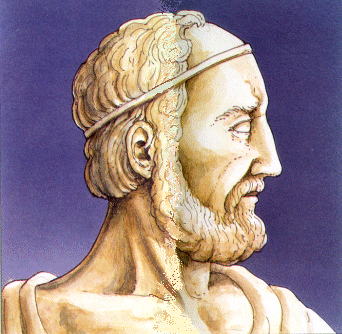UOMINI E DEI – Innanzitutto, “la società omerica”, sottolinea Guido Paduano, traduttore del testo originale, “mescola uomini e dèi nello stesso gruppo che organizza l’orizzonte dei giudizi e delle attese“. Ma, se il mescolarsi del piano umano con quello divino non è certo esclusiva del mondo ‘pagano’ (basti pensare all’origine del Cristianesimo), nei monoteismi la volontà divina, laddove si manifesta, lo fa in maniera lineare e “unidirezionale”, mentre nel mondo omerico, non solo uomini e dèi, ma anche tra loro stessi gli dèi si combattono, si aiutano, discutono, si confidano, si fanno giustizia e reclamano vendette, dimostrando di possedere la forza e l’immortalità ma certo non l’unità, rappresentata soltanto dalla figura “sovrana” di Zeus che riconcilia, con le buone o con le cattive, le diatribe tra gli “agenti sovrannaturali”. Il piano divino, insomma, ci riserva indubbiamente una complessità maggiore, meno artificiosa e costruita rispetto ai monoteismi, tanto che è Zeus stesso, prima della distruzione di Troia, a dichiarare: “Tra le città che gli uomini terrestri abitano sotto il sole e sotto il cielo stellato, più di tutte nel mio cuore onoravo la sacra Ilio e Priamo e il popolo del valoroso Priamo, perchè sugli altari non mancava mai la mia parte di libagioni e di grasso, l’onore che ci è dovuto” (IV). Quanto al mescolarsi del piano umano con quello divino, che potrebbe far pensare ad un racconto fiabesco o ad una visione farsesca del sovrannaturale, di per sé dimostra soltanto una concezione del mondo che non può prescindere da ciò che non è visibile. Talmente distante dal materialismo filosofico moderno che perfino i racconti umani non possono fare a meno della rappresentazione simbolica della partecipazione divina.
L’ETICA DELLA VIOLENZA – Venendo finalmente ai fatti narrati, “bisogna ben guardarsi dal sovrapporre all’epica omerica una dimensione che possa dirsi a qualunque titolo pacifista: l’Iliade è interamente immersa nel codice della violenza istituzionalizzata, che non viene intaccato nè dalla profonda e universale pietà, e neanche dai dubbi sporadici sulla fondatezza della guerra”, premette ancora Paduano. “Si confondono volutamente”, prosegue, “l’aggressività istituzionale e quella privata, sebbene la prima sia altrettanto costruttiva della comunità e della socialità quanto la seconda ne è distruttiva […]. Dobbiamo allora distinguere da questa un’ulteriore opposizione: l’integrazione sociale di Ettore contro l’individualismo egoistico di Achille“. Ed è proprio in questa chiave che vanno lette le parole di Zeus nei confronti di Ares: “Banderuola, non venirmi qui a piangere; tu mi sei il più odioso fra tutti gli dèi d’Olimpo perché sempre ti sono cari i litigi, le battaglie, le guerre”. Non si tratta di un’improvvisa ricaduta pacifista del sovrano celeste, ma del biasimo nei confronti di una violenza a scopo puramente privato, illegittima. In ogni caso, la violenza è considerata e descritta con realismo. Né nascosta, né esaltata, né demonizzata. In verità, tutto nell’Iliade – ancor più nell’Odissea ma con sostanziali differenze nelle tematiche – è realismo: la gloria non cela i dolori della guerra, l’atto eroico non nasconde le mostruosità dei colpi e delle ferite, l’onore non disprezza la ricchezza materiale. “Il figlio di Atreo”, racconta Omero, “incalzava gridando, con le mani invincibili sporche di sangue”. Non c’è un altro lato della medaglia: lo strumento dell’eroe è la violenza. Fatta di ossa rotte, scudi e crani trapassati, occhi inflizati, braccia spezzate.
Ogni forma di moralismo è assente. Ed il realismo non è perciò “macchiavellico” ma è presa di coscienza delle cause, dei fini, dei mezzi e così anche delle loro conseguenze. “Odisseo da dietro gli piantò nel dorso la lancia in mezzo alle spalle, e gli trapassò il petto”. Non c’è pietà per chi fugge. Celebre per la sua proverbiale intelligenza, prode in battaglia, ottimo re, non per questo Odisseo è risparmiato dalla brutalità. E nel successivo poema a lui dedicato, peraltro, le scene di violenza descritte sono ancora più dure e macabre: al momento del ritorno a Itaca, la sua vendetta su Proci e traditori non è quella dell’eroe che stermina i nemici circondato da un’aura di splendore ma, anzi, è minuziosa e particolareggiata la descrizione dei cadaveri appesi e della scena del delitto (non più un campo di battaglia ma il focolare domestico che rende ancor più brutale la violenza). Non è forse un caso se i duelli sono quasi sempre raccontati attraverso la similitudine con il mondo animale: “Altri ancora fuggivano nella pianura, come giovenche spaventate dal leone piombato nel buio notturno; per quella a cui si avvicina si apre l’abisso di morte: le spezza il collo afferrandola coi forti denti prima, poi succhia il sangue e tutte le viscere; così li inseguiva il figlio di Atreo, il potente Agamennone” (XI).
LA GLORIA AL SERVIZIO DELLA PATRIA – La gloria conquistata in battaglia, generata essenzialmente dal coraggio, è ovviamente il tema cruciale. E’ il coraggio che scolpisce nella memoria il ricordo dell’eroe, che lo innalza davanti agli uomini e ne fissa l’esempio nel ricordo dei posteri e della sua stirpe, il che rimanda anche al valore pedagogico e concreto della gloria stessa, poiché spinge ciascuno ad elevarsi, per inseguirne la grandiosità e, di conseguenza, rende più forte la patria. Mentre, al tempo stesso, viene fuori il ruolo centrale della stirpe, che conferisce ad ognuno la responsabilità di esserne degno, in una concezione anti-individualistica ovviamente sconosciuta al mondo moderno, che naturalmente rafforza tali popoli rispetto a quelli privi di un’identità collettiva. È perciò sul coraggio, ovviamente, che vengono spese le frasi più significative del poema, le più grandi lezioni di vita: “Vorrei almeno essere moglie di un uomo più forte, che capisse il biasimo e la vergogna di fronte agli uomini. Ma lui non ha e non avrà mai, neanche in futuro, un cuore saldo, e credo che dovrà scontarne la pena” (IV), confessa Elena, causa scatenante della guerra, al valoroso cognato Ettore, “figlio di Priamo” .
Rapita al suo legittimo sposo dal biondo Paride, che ha così costretto il suo popolo ad anni di assedio per un capriccio, Elena stessa conosce una vergogna che lui non dimostra di avere, più incline ad assecondare i piaceri più che i suoi doveri, in contrapposizione netta e costante con Ettore che, pur fedele alla sua Andromaca – il loro incontro prima della battaglia è una delle scene più toccanti e significative dell’Iliade – padre affezionato e marito affettuoso, in quanto principe mette al primo posto il dovere verso la patria: “Terribilmente mi vergognerei di fronte ai Troiani e alle Troiane dai lunghi pepli”, dichiara con fermezza alla sua sposa, “se come un vile mi tenessi lontano dalla battaglia; non a questo mi spinge il mio cuore, poiché da sempre ho imparato ad essere forte e a combattere in prima fila tra i Troiani, dando grandissima gloria a mio padre e a me stesso” (VI). La gloria è individuale, certo, ma esiste soltanto in relazione al servizio della patria. Ed il pur invincibile Achille, amante delle razzie, spietato con il cadavere di Ettore, leader solitario dei suoi Mirmidoni, tradendo più volte il suo individualismo fino al ritiro dalla battaglia per un torto subito dal re Agamennone, capo della spedizione contro Troia, è elogiato in via esclusiva per le sue doti personali e nelle descrizioni non è circondato dalla stessa aura di eroismo che invece avvolge Ettore, adorato dal suo popolo pur nella sua umanità, che affronta in tutta la sua debolezza nel momento dello scontro per lui mortale con Achille, prima del quale tenta la fuga in preda al panico, fino a ritornare in sé andando incontro al Pelide ed al suo destino.

Ed è forse ancora più chiaro Odisseo quando, nel libro II, col malumore che serpeggia tra i Greci, stanchi e pronti a salpare con le loro navi per tornarsene a casa, con durezza sprona nobili e sudditi (come in questo caso) che vogliono fuggire: “Sciagurato, stattene fermo e seduto e ascolta gli altri che sono migliori di te; tu non hai valore né forza; non conti niente in battaglia e niente in consiglio; non vorremmo, qui dentro, regnare tutti! Non è un bene l’autorità di molti: ci deve essere un solo capo, un re a cui il figlio di Crono dal tortuoso pensiero ha dato lo scettro e le leggi, perché decida per gli altri“. Troviamo qui una perfetta e concisa elaborazione teorica sulla legittimazione del potere sovrano secondo il “diritto divino”, centrale per secoli fino all’Illuminismo, qui peraltro efficacemente spiegata nel suo significato concreto: il valore e la forza, è attraverso questi “segni” che il dio “seleziona” un capo. In questi indizi di superiorità consiste la sua legittimazione da parte del dio, che è consacrata dalla capacità stessa di farsi rispettare e, quindi, obbedire, poiché nel concetto di sovranità vengono in rilievo appunto tanto la capacità di creare diritto quanto la forza di farlo rispettare. E così niente è scontato e la gerarchia è costantemente in gioco sulla base dei comportamenti: i gradi si conquistano sul campo, concetto da chiarire per non cadere, sul fronte opposto, nello stesso vuoto teorico della legittimazione democratica rifugiandosi nella difesa strenua di una forma, qual è la regalità, che non è per forza sostanza.
Ciò che peraltro ribadiva Evola in una frase troppo spesso dimenticata o ignorata dagli stessi “evoliani” che, sulla base di questi ed altri punti delicati della sua costruzione “metapolitica”, hanno influenzato in senso conservatore l’ambiente in cui coestisono tutti coloro che guardano con interesse all’opera ed al significato del fenomeno fascista. Premesso quanto approfondito nella nostra breve digressione, Odisseo colpisce Tersite con lo scettro, colpevole di aver insultato pubblicamente Agamennone (verso il quale Odisseo non mostrerà certo servilismo in altre occasioni). E, coerentemente con l’ideale greco del “kalòs kai agathòs” (bello e buono) tipico dell’eroe, Tersite, per contrasto, è così significativamente descritto: “Tersite aveva in cuor suo molte parole confuse, inutili, disordinate, ostili ai sovrani, ma gli sembrava che avrebbero divertito gli Achei. Era il più brutto tra i Greci venuti a Troia: si trascinava zoppo ad un piede, le spalle curve rientranti sul petto; sopra, la testa era appuntita e coperta da rada peluria”.
PATRIA E COMUNITA’ DI DESTINO – La centralità della gloria, del coraggio e della gerarchia, quindi, conducono direttamente all’idea di patria. Non si tratta di “semplice” patriottismo. No. Il concetto di patria qui presente va più a fondo ed è tutt’uno con l’etica anti-individualistica a cui abbiamo accennato e, quindi, con l’idea di Stato come comunità (in opposizione allo Stato come società, di matrice individualistica/liberale). È così, ad esempio, che Poseidone comanda ai greci: “Il guerriero prode che indossa un piccolo scudo lo ceda a un soldato peggiore e lui lo prenda più grande” (XIV). Il contrario di quanto avverrebbe in democrazia. Oppure ancora Ettore, che rivolge ai suoi questo particolare invito: “Chi di voi, colpito da lontano o da vicino, incontrerà il destino di morte, muoia: non è vergogna per lui morire difendendo la patria” (XV). È lui, strenuo difensore delle mura di Troia, a ritornare, nel libro XII, di nuovo su questo punto, evidentemente cruciale per i troiani, che appaiono sempre molto compatti nonostante muoiano e soffrano per il codardo Paride, mentre i greci sono spesso divisi pur trovandosi dalla parte del giusto, avendo il principe troiano infranto i patti: “Uno solo è l’augurio migliore, combattere per la patria”. È questo che tiene unito il popolo della “sacra Ilio”.
Nonostante Ettore venga poi ucciso, infatti, gli achei prenderanno Troia soltanto grazie ad un inganno di Odisseo che trova non pochi oppositori fra i suoi pari. “Crediamo forse di avere dietro di noi chi ci dà aiuto, o qualche muro più forte, che ci difenda dalla sciagura? Non c’è vicino nessuna città dai saldi bastioni dove possiamo difenderci avendo rinforzi dal popolo: siamo nella piana dei Troiani dalle forti corazze, sospesi verso il mare, lontani dalla nostra patria. Nelle nostre braccia è la luce, non nell’indolenza in battaglia” (XV), grida Aiace – impavido e imponente, uscito indenne dallo scontro con Ettore, allo stremo delle sue forze – ai suoi che si stanno perdendo d’animo vedendo i guerrieri troiani imperversare a due passi dalle loro navi e dal loro campo. “Nelle nostre braccia è la luce”. E’ un uomo d’azione Aiace, un baluardo, ma questa sua frase mette in rilievo due cose fondamentali: la forza che proviene dal combattere per difendere la propria patria e i propri cari, “privilegio” che i greci non hanno, e la capacità di fare della propria idea (la giusta causa) la propria patria, supplendo alla forza che conferisce ciò che è (pur sempre) materiale con la forza che si ha dentro: il proprio spirito. “Nelle nostre braccia è la luce”.
INVIOLABILITA’ DEL SACRO
Inutile dire, in proposito, che il sacro permea anche il linguaggio dei personaggi e ne sancisce l’inviolabilità, fungendo così da garanzia degli accordi: “Zeus padre non aiuterà gli spergiuri, e quelli che per primi hanno infranto i patti” (Agamennone, IV). E ancora il capo degli Achei, nel libro XIX: “Mi sia testimone per primo Zeus, il dio massimo e sommo, la Terra, il Sole e le Erinni che sotto terra puniscono gli uomini che giurano il falso”. I patti sono sacri. Così come gli atti rituali: “non oso libare a Zeus il vino lucente con mani impure; il dio dalle nuvole nere non è lecito pregarlo sporchi di sangue e di fango”. In tutto questo – guerra ed eroismi, rituali e giuramenti, gloria e brutalità, fede e razionalità – consiste la “religiosità” dell’Iliade. E se l’Europa e i suoi popoli avranno una chance di rinascere, dopo tutto, dipenderà esattamente dalla nostra capacità di far risorgere quell’etica ormai sovvertita. Non sarebbe male iniziare a spiegarlo agli studenti dei nostri licei.
Emmanuel Raffaele